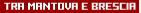LE PLURALITÀ FIGURATIVE IN MOSTRA A MEDOLE
 Dal 4 al 18 marzo si è svolta, nella consueta cornice della Torre Civica di Medole, la collettiva Pluralità figurative. L’intento dell’esposizione è stato quello di richiamare l’attenzione sulla figura, come esigenza dalla quale ripartire per rifondare una nuova idea di arte. La figura si presenta come fondamento della raffigurazione, in netto contrasto con l’astrazione informale non più sentita come unico modus operandi. I 28 artisti in mostra, ognuno a suo modo, hanno codificato un mondo dove la referenzialità non solo è possibile, ma è assolutamente necessaria. Le tenui figurazioni di Giuseppe De Luigi, semplificate secondo la lezione di Rothko; le classiche sculture di Gianpietro Moretti, tra mitologia e sintesi vitalistica; le intime atmosfere di Dal Prato, dove il roseo abito della fanciulla sembra sbocciare come la vita che racchiude; le brume divisioniste-chiariste di Mario Porta, inquiete e movimentate; l’encausto di Arturo Raffaldini, quasi a donare un gradiente sudoriparo alle superfici murate; la monocromaticità di Enrico Longfils, dove le figure combattono tra i poli della coesione e del disfacimento; l’antica vallata di Archimede Bresciani, che più che vegetale sembra uno spaccato delle fibrose fasce muscolari; le piccole e massicce sculture di Aldo Rossi, in cui la sintesi elimina la connotazione ma lascia integra la denotazione; il plesso coloristico azzurro-violaceo di Giancarlo Cigala, calato su piccoli angoli di paradiso romantici e quieti; i violenti contrasti cromatici di Giulio Perina, dove l’anti-naturalismo non approda ai lidi informi; i raffinati scorci mantovani di Alberto Marani, dove il ciottolato è trattato come le onde lagunari di Canaletto; le sacre figure di Dino Coffani, sofferenti ma illuminate dalla salvifica luce divina; le piccole figurine di Giuseppe Gorni, dove la materia trasuda fatica come in Giacometti; il nudo sognante di fattura simbolista di Aldo Bergonzoni.
Dal 4 al 18 marzo si è svolta, nella consueta cornice della Torre Civica di Medole, la collettiva Pluralità figurative. L’intento dell’esposizione è stato quello di richiamare l’attenzione sulla figura, come esigenza dalla quale ripartire per rifondare una nuova idea di arte. La figura si presenta come fondamento della raffigurazione, in netto contrasto con l’astrazione informale non più sentita come unico modus operandi. I 28 artisti in mostra, ognuno a suo modo, hanno codificato un mondo dove la referenzialità non solo è possibile, ma è assolutamente necessaria. Le tenui figurazioni di Giuseppe De Luigi, semplificate secondo la lezione di Rothko; le classiche sculture di Gianpietro Moretti, tra mitologia e sintesi vitalistica; le intime atmosfere di Dal Prato, dove il roseo abito della fanciulla sembra sbocciare come la vita che racchiude; le brume divisioniste-chiariste di Mario Porta, inquiete e movimentate; l’encausto di Arturo Raffaldini, quasi a donare un gradiente sudoriparo alle superfici murate; la monocromaticità di Enrico Longfils, dove le figure combattono tra i poli della coesione e del disfacimento; l’antica vallata di Archimede Bresciani, che più che vegetale sembra uno spaccato delle fibrose fasce muscolari; le piccole e massicce sculture di Aldo Rossi, in cui la sintesi elimina la connotazione ma lascia integra la denotazione; il plesso coloristico azzurro-violaceo di Giancarlo Cigala, calato su piccoli angoli di paradiso romantici e quieti; i violenti contrasti cromatici di Giulio Perina, dove l’anti-naturalismo non approda ai lidi informi; i raffinati scorci mantovani di Alberto Marani, dove il ciottolato è trattato come le onde lagunari di Canaletto; le sacre figure di Dino Coffani, sofferenti ma illuminate dalla salvifica luce divina; le piccole figurine di Giuseppe Gorni, dove la materia trasuda fatica come in Giacometti; il nudo sognante di fattura simbolista di Aldo Bergonzoni.
Pausa.
Secondo piano. Il pescatore dai tratti marcatissimi di Giulio Salvadori, come fulminato dall’arte africana; le melanconiche presenze di Nicola Biondani, bloccate in una solitudine esemplificata dalla mancanza di dialogo e, di contro, le scattanti, pronte, energiche statue di Aldo Falchi, tra stregoneria e mito; le ampie campiture di Domenico Gentile, tra l’ à plat e l’elasticità materica; i ricordi della famiglia De Chirico di Michele Della Maestra, con un panneggio che si situa a metà tra l’Agilulfo di Calvino e un personaggio magrittiano; il memento mori di Franco Ferlenga, suggerito da vecchi barattoli o esemplificato da La vittima; le partizioni di colore di Nicolaje Krapivin, astratte se fissate da lontano ma così figurative; la forza naturalistica e analitica di Clara Magrograssi e Angelo Boni, dove la minuziosità diventa esercizio immolato alla bella rappresentazione; il recupero ontogenetico dell’arte attuato da Nene Nodari; le generose forme accarezzate da un erotico Velo rosa di Ugo Celada da Virgilio; il mito che emerge dal magma informe di Vittorio Bustaffa; l’irriverente raffigurazione di un cardinale di Albano Seguri. Mi si scuserà il periodare rapsodico, ma forse il miglior modo di riproporre la grande mole d’arte presente in quell’esposizione.
Commenti »
La URI per fare un TrackBack a questo articolo è: http://www.civetta.info/wp-login.php/wp-images/smilies/wp-admin/wp-trackback.php/wp-trackback.php/wp-admin/wp-admin/wp-trackback.php/wp-trackback.php/982
Ancora nessun commento
feed RSS per i commenti a questo articolo.
Lascia un commento
Attenzione: i commenti compariranno sul sito previa approvazione del moderatore
Righe e paragrafi vanno a capo automaticamente, l’indirizzo e-mail non viene mostrato, HTML è permesso: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>